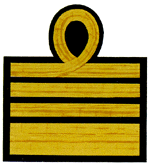Dal vivo P. F. era più squallido che in video. Grassoccio, sudaticcio, era l'esemplare-tipo di questa repubblichetta: viscido, sboccato, amante della battuta di pessimo gusto, si avvicinava a te con l'atteggiamento di chi è il padrone del cielo e della terra.
- È un piacere conoscerla.
- Tu sei...?
- Simone Bocucci. Il nuovo aiuto regista.
- Bocucci. Un cognome che ha fatto grande questo Paese.
- Troppo buono, dottor F.
- Smettila di chiamarmi dottore. Chiamami P., siamo colleghi.
- Lo metterò nel curriculum: P. F. mi ha detto di dargli del tu.
- Smettila di fare il leccaculo, Simone. Col cognome che porti non ne hai bisogno.
P. F. sorrise. Mi schiacciò l'occhio e viscido com'era arrivato se ne andò. Maledetto F., servo prostrato di un padrone inesistente, un giorno ti schiaccerò. Un giorno la rivoluzione proletaria prenderà il sopravvento, un giorno i traditori saranno passati per le armi. Un giorno il sol dell'avvenire illuminerà questo Paese, riporterà la giustizia e la pace.
- Simone?
- Sì, Enrico?
- Oggi hai l'occasione per far vedere quel che vali.
- Porto i caffé?
- Smettila. Oggi è una giornataccia, con 'ste tre puntate da registrare e tutto il resto. Io ho bisogno di tempo, di concentrazione. Mi serve il tuo aiuto: prendi la troupe di Miraglia e vai nello studio 32 con Antonio e Giulio. Girerai la tua prima telepromozione: “Regia di Simone Bocucci”. Come ti sembra?
- Grandioso, capo. Grandioso.
Le odio, queste telepromozioni. Strumento del demonio, corruttrici di popoli. Avamposto del consumismo, di una società basata sul nulla. Di una società che merita di essere governata da Bartolini e dai suoi servi sciocchi: ma verranno, i giorni del giudizio, verrà il potere del popolo, verrà la libertà degli oppressi.
- Maledetti occhiali, li hai visti?
- Gli occhiali? Ancora li cerchi in giro per casa? Non hai sentito la novità?
- Quale novità?
- Sei stanco di sbattere contro le porte alla ricerca dei tuoi occhiali? Sei stanco di vagare nel buio senza trovare quel che cerchi? Da oggi non sarà più necessario: grazie ai nuovi occhiali Gombini basterà pigiare un interruttore e gli occhiali squilleranno. Guarda i miei: non posso perderli più.
- E poi che belli.
- Già: sono stati disegnati dalle firme più prestigiose del panorama internazionale. I miei sono di Armeni, ma guarda qui: questi sono stati disegnati da Amaro&Soprabito, questi altri da Versaccio. Ma la collezione è molto più ricca: Fofò Canale, Gabriel Bulgaro, Gianluca Doré. Non c'è che l'imbarazzo della scelta.
- Gombini, come ho fatto senza di voi?
Buona la prima e vaffanculo. E vaffanculo a tutti voi. Torno a casa, aspetto il mio momento. Fra non molto arriverà, già me lo vedo: P. F. conduce il suo show, puttanelle e mezzi uomini si danno da fare per guadagnare un primo piano, e io intanto ripeto il mio mantra finché non arriva il mio turno. “Bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, evviva il comunismo e la...”.
- Pubblicità.
- È un piacere conoscerla.
- Tu sei...?
- Simone Bocucci. Il nuovo aiuto regista.
- Bocucci. Un cognome che ha fatto grande questo Paese.
- Troppo buono, dottor F.
- Smettila di chiamarmi dottore. Chiamami P., siamo colleghi.
- Lo metterò nel curriculum: P. F. mi ha detto di dargli del tu.
- Smettila di fare il leccaculo, Simone. Col cognome che porti non ne hai bisogno.
P. F. sorrise. Mi schiacciò l'occhio e viscido com'era arrivato se ne andò. Maledetto F., servo prostrato di un padrone inesistente, un giorno ti schiaccerò. Un giorno la rivoluzione proletaria prenderà il sopravvento, un giorno i traditori saranno passati per le armi. Un giorno il sol dell'avvenire illuminerà questo Paese, riporterà la giustizia e la pace.
- Simone?
- Sì, Enrico?
- Oggi hai l'occasione per far vedere quel che vali.
- Porto i caffé?
- Smettila. Oggi è una giornataccia, con 'ste tre puntate da registrare e tutto il resto. Io ho bisogno di tempo, di concentrazione. Mi serve il tuo aiuto: prendi la troupe di Miraglia e vai nello studio 32 con Antonio e Giulio. Girerai la tua prima telepromozione: “Regia di Simone Bocucci”. Come ti sembra?
- Grandioso, capo. Grandioso.
Le odio, queste telepromozioni. Strumento del demonio, corruttrici di popoli. Avamposto del consumismo, di una società basata sul nulla. Di una società che merita di essere governata da Bartolini e dai suoi servi sciocchi: ma verranno, i giorni del giudizio, verrà il potere del popolo, verrà la libertà degli oppressi.
- Maledetti occhiali, li hai visti?
- Gli occhiali? Ancora li cerchi in giro per casa? Non hai sentito la novità?
- Quale novità?
- Sei stanco di sbattere contro le porte alla ricerca dei tuoi occhiali? Sei stanco di vagare nel buio senza trovare quel che cerchi? Da oggi non sarà più necessario: grazie ai nuovi occhiali Gombini basterà pigiare un interruttore e gli occhiali squilleranno. Guarda i miei: non posso perderli più.
- E poi che belli.
- Già: sono stati disegnati dalle firme più prestigiose del panorama internazionale. I miei sono di Armeni, ma guarda qui: questi sono stati disegnati da Amaro&Soprabito, questi altri da Versaccio. Ma la collezione è molto più ricca: Fofò Canale, Gabriel Bulgaro, Gianluca Doré. Non c'è che l'imbarazzo della scelta.
- Gombini, come ho fatto senza di voi?
Buona la prima e vaffanculo. E vaffanculo a tutti voi. Torno a casa, aspetto il mio momento. Fra non molto arriverà, già me lo vedo: P. F. conduce il suo show, puttanelle e mezzi uomini si danno da fare per guadagnare un primo piano, e io intanto ripeto il mio mantra finché non arriva il mio turno. “Bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, evviva il comunismo e la...”.
- Pubblicità.